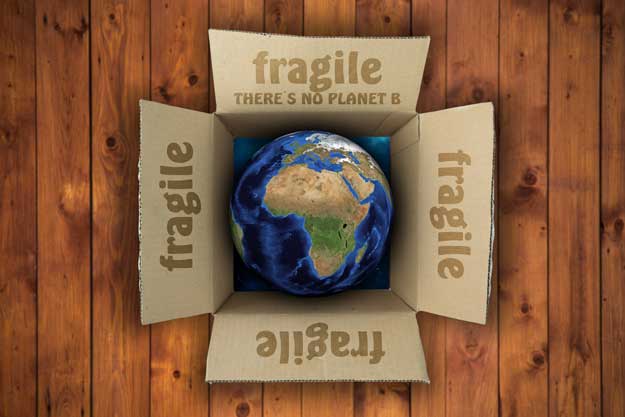Il nostro organismo di controllo e certificazione supporta il 15° Sustainable Foods Summit in programma ad Amsterdam il 4 e 5 luglio. Ecco i temi sul tavolo e i nodi da sciogliere…
Quando il gioco per la sostenibilità si fa duro, i duri rilanciano sulla sostenibilità. Parafrasando il motto reso immortale da John Belushi in Animal house (“When the going gets tough… let the tough get going”), è questo lo spirito con cui Suolo e Salute sostiene con la sua partnership la 15 edizione del Sustainable Foods Summit, in programma ad Amsterdam il 4 e 5 luglio.
I temi sul tavolo
Organizzato da Ecovia Intelligence, una società di ricerca, consulenza e formazione sulla produzione e consumo equo&sostenibile con sede a Londra, il Sustainable Foods Summit si occupa dal 2009 dello sviluppo sostenibile dell’industria alimentare. Come si stanno evolvendo i sistemi di sostenibilità e i marchi di qualità ecologica nell’industria alimentare? Con la crescente proliferazione delle etichette, quali sono le prospettive di un unico standard di sostenibilità per i prodotti alimentari? Quali sono le prospettive future per gli alimenti a base vegetale? Quali sviluppi si stanno verificando negli ingredienti sostenibili? In che modo le aziende del settore food & beverage possono muoversi verso la circolarità? In che modo gli operatori possono chiudere i cicli dei materiali? Sono solo alcuni dei temi affrontati nella due giorni di Amsterdam.
La biodiversità degli ingredienti alimentari
La quindicesima edizione europea del summit intende in particolare approfondire il tema dell’innovazione nel campo delle alternative sostenibili agli ingredienti alimentari.
Jeroen Hugenholtz, co-fondatore di NoPalm Ingredients, spiegherà ad esempio una nuova alternativa biotecnologica all’olio di palma. Questa start-up ha sviluppato infatti una tecnologia basata sulla fermentazione da parte di lieviti di biomasse alimentare per la produzione di oli e grassi alimentari saturi e monoinsaturi.
Dorothy Shaver, Global Food Sustainability Director di Unilever, parlerà invece dell’importanza della biodiversità degli ingredienti. Specie alimentari poco conosciute di cereali, leguminose,ecc, edibili sotto forma di tuberi, germogli, verdure, noci e semi, possono infatti avere un minore impatto ambientale e un valore nutrizionale più elevato. Mentre molte aziende alimentari si preparano ad affrontare i nuovi vincoli del regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero (EUDR), che dovrebbe essere implementato nel dicembre 2024, un esperto del settore fornirà indicazioni su come garantire che catene di approvvigionamento agricolo conformi.
Il ruolo sempre più decisivo degli enti di certificazione
«E questo è solo l’ultimo esempio – commenta Alessandro D’Elia, direttore generale di Suolo e Salute – che mostra come trasparenza e tracciabilità stiano diventando sempre più importanti per consolidare le partnership tra produttori, trasformatori e distributori all’interno delle filiere agroalimentari». «Organismi di certificazione e controllo come il nostro assumono un ruolo sempre più importante nel consolidare la catena del valore».
Al centro della sessione Social Value il Summit di Amsterdam mette invece il tema della sostenibilità sociale della produzione di cibo. La sessione inizierà con un intervento di Julian Baggini, intellettuale inglese cofondatore della rivista The Philosophers’ Magazine , sull’evoluzione del ruolo del cibo nella società moderna e su come i temi della sostenibilità stiano influenzando la produzione alimentare e le scelte dei consumatori. Julian condividerà estratti dal suo prossimo libro, “How The World Eats: A Global Food Philosophy”.
L’impatto sociali delle catene di approvvigionamento alimentare
Cristina Figaredo di FAIRR Initiative (una rete internazionali di investimenti sostenibili) proporrà un nuovo metodo per analizzare i rischi sociali legati alle catene di approvvigionamento alimentare e agricolo e un approccio per mitigare tali rischi. Claudio Krause di Fairtrade International evidenzierà l’impatto positivo dell’approvvigionamento equo e solidale sui piccoli produttori. Secondo l’organizzazione, nel 2023 le organizzazioni di produttori hanno ricevuto 222 milioni di euro a titolo di Premio Fairtrade, a beneficio soprattutto dei produttori di banane, cacao, zucchero, caffè e tè.
Deborah Vorhies, CEO di FairWild Foundation, spiegherà come lo standard FairWild promuova l’approvvigionamento sostenibile di piante selvatiche, bacche e frutti correlati. Aduna Superfoods, pioniere dell’approvvigionamento etico, condividerà le sue esperienze nell’approvvigionamento e nella commercializzazione di baobab, moringa e fonio dall’Africa attraverso il suo CEO e co-fondatore Andrew Hunt.
La sessione di marketing si aprirà con un keynote di Bibianne Roetert di Tony’s Chocolonely. Nato come protesta contro il cioccolato convenzionale nel 2005, è ora il marchio di cioccolato leader nei Paesi Bassi e si è espanso in Europa e negli Stati Uniti. Bibianne parlerà della strategia di marketing del brand, spiegando come sta sensibilizzando l’opinione pubblica sullo sfruttamento della manodopera nelle catene di approvvigionamento del cacao.
«La domanda chiave – conclude D’Elia – a cui il Summit è chiamato a trovare una risposta è: “Nell’attuale clima economico, come possono incoraggiare i consumatori ad acquistare prodotti sostenibili e ad essere più responsabili?”».